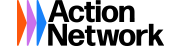A colloquio con Sandro Mattioli responsabile salute Arcigay Il Cassero.
Da Pegaso19 – inverno 2009/2010
Lo stigma sociale che colpisce le persone sieropositive ha molte somiglianze con quello omofobico. Allora come spieghi che anche gay e lesbiche hanno pregiudizi nei confronti delle persone HIV+?
Per prima cosa, anche gay e lesbiche vivono in Italia: dove la cultura del divide et impera fa da padrona. In quanto persone lgbt ci sentiamo appartenenti a qualcosa d’altro dal resto della società, creiamo una comunità chiusa, che lascia fuori l’altro, il diverso da noi, tra cui le persone sieropositive. La seconda ragione è che non c’è mai stata la volontà politica dell’associazione di progettare un concreto piano pluriennale rispetto alla lotta all’HIV. Si agisce solo a spot, in maniera disorganica. Ci sono anche segnali incoraggianti, come la partecipazione di Arcigay alla Conferenza Mondiale AIDS in Messico, la presenza nella Consulta Nazionale AIDS, il congresso ICAR. Ma la mancanza di progettualità ha prodotto una cattiva conoscenza tra le differenti identità nella nostra comunità, ha impedito di far passare l’idea che esistono le persone omosessuali HIV+, un po’ come succede agli omofobi che ignorano i gay e le loro istanze.
Come vive oggi una persona gay HIV+ italiana la sua sessualità e la sua vita di relazioni?
Anche in Italia è arrivata, come già accadde in altri paesi, la richiesta forte di relazione tra gay sieropositivi, una gran voglia di non avere questo peso addosso, e di non affrontare la paura del doversi dichiarare agli altri. C’è voglia di appartenenza e identificazione in un sottogruppo nel sottogruppo. Non si vuole più avere paura di subire un’ulteriore discriminazione. Ci sono delle similitudini impressionanti con il percorso di visibilità e di affermazione gay negli anni ‘70. Anche in questo senso poi ritorna il nostro deficit di programmazione. L’associazione viene percepita come esterna e molte persone HIV+ non hanno più il coraggio di affrontare gli spazi associativi.
Perché bisogna fare il test HIV?
Cambia (e in meglio!) sapere di essere HIV+ presto, anziché saperlo quando si è già in AIDS: le terapie possono essere più efficaci, e non sei esposto a molte malattie in più… è necessario conoscersi, fare il test ed essere coscienti del proprio stato sierologico.
Nella tua esperienza di responsabile salute hai incontrato molti omosessuali che hanno appena scoperto di essere HIV+…
Sì, ahimé, soprattutto giovani. Il 70% nella fascia d’età dei 20-29, in qualche caso, addirittura allegramente inconsapevoli, come se la cosa non li riguardasse, fatalisti, ormai è andata così. La maggioranza di questi è molto spaventata, sono preoccupati di morire. È disarmante l’assoluta ignoranza di tutti su cosa gli sta succedendo, su cosa li aspetta, su cosa chiedere all’infettivologo. C’è un ragazzo che mi ha detto: ma io pensavo di essere “coperto” per il solo fatto di avere fatto il test una sola volta mesi prima. È importante che la persona HIV+ sia in grado di gestire il suo stato. Io consiglio di fare domande chiare e anche banali sui dati medici, di prendere un quaderno e scrivere ogni dubbio che viene in mente.
Nella guida per gay HIV+ di www.casserosalute.it ho pensato ai giovanissimi e per prima cosa di dire loro niente panico, non hai un’alone viola che ti marca, sei sempre tu, guardati allo specchio. E di scrivere un elenco di persone fidate a cui confidare la propria esperienza per creare una rete tutelante.
Per superare ogni pregiudizio è necessaria la conoscenza reciproca tra le persone. Cosa può fare Arcigay per promuovere la visibilità delle persone omosessuali HIV+?
Una persona HIV+ dovrebbe essere considerata solo una persona con un virus, come quello dell’influenza. Basta ipocrisia, ci vuole maggiore visibilità e tanta informazione. Arcigay potrebbe smettere di scrivere documenti pieni di belle parole e lasciarle inesitate. E continuare a fare iniziative di concreta informazione, come la conferenza nazionale organizzata a Bologna nel 2008 che aveva lo scopo di diffondere le informazioni fornite dalle grandi conferenze internazionali. Chi partecipa a questo tipo di eventi può a sua volta informare, a pioggia all’interno della comunità, e con linguaggi più semplici e diretti, chi non ha partecipato, e dare strumenti di conoscenza e confronto.
Ci piace promuovere l’idea di sessualità consapevole, conscia dei comportamenti che mette in pratica e dei rischi legati alla prevenzione da malattie a trasmissione sessuale. Quanto è importante superare la sessuofobia diffusa e parlare chiaro per diffondere messaggi efficaci?
È assolutamente necessario, bisogna dare informazioni chiare e secche!
Queste sono le tre regole del safer sex, fregandosene dei politicanti o degli anatemi vaticani:
1) mai penetrare o farsi penetrare senza preservativo,
2) mai sperma in bocca,
3) mai sangue mestruale in bocca.
La campagna Arcigay Sex Symbol era sessuata, è stata un buon esempio per iniziare un percorso per parlare dei corpi, del sesso. Da quando c’è il virus, negli altri paesi si parla in modo esplicito, in Italia c’è un livello ancora troppo forte di ipocrisia. Questa idea è sostenuta da ricerche scientifiche di paesi più evoluti del nostro: se si veicolano messaggi di prevenzione anche utilizzando materiale fotografico esplicito (in Italia, porno!) è dimostrato come il contagio sia diminuito. Ma che percezione del rischio c’è purtroppo in Italia, in un paese dove a livello istituzionale non si può nominare il preservativo? È una comunità spaventata, impregnata di pregiudizi e ignorante. Basti pensare all’idea maschia italiana del rifiuto del preservativo come ostacolo al piacere e sminuimento della mascolinità.
Qual è la tua idea di benessere psicofisico rivolto alle persone lgbt?
Il benessere ha a che vedere con stare bene con se stessi e con gli altri, con l’accettazione. Mentre tutto quello che ha a che vedere con sessuofobia, omofobia ed ignoranza non è benessere.
Foto: Stefano Bordieri – Mettiamo in gioco i nostri corpi – Pegaso19