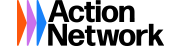Tragico epilogo per una coppia gay con figlio, che non viene definita tale.
Si muore come si vive: è così per la verità che ciascuno di noi porta con sé anche quando va via. Ma ai funerali irrompe la storia ufficiale, l’immagine dell’estinto viene suggellata da chi resta con pochi tratti che passano per fedeli. Parole potenti, spesso le ultime pronunciate in pubblico sul conto di chi non c’è più. È uno dei momenti prediletti dal pregiudizio. Se trova terreno fertile, entra in campo. L’ultima scena esibita, prima di calare il sipario, è «rispettabile», non sempre rispettosa.
Nel caso dei gay e delle lesbiche spessissimo si oscurano – salvo allusioni – i loro amori. Improvvisamente diventano quello che in vita non sono stati mai, se non nell’immaginario di chi li voleva tali. Se ai funerali ci sono il partner, la madre di lui, gli amici che sapevano, costoro diventano presenze che provano emozioni incomprensibili per gli altri, perché non condivise. Quanti si stringono intorno al dolore atroce di una scomparsa diventano un gruppo, e non solo un numero di persone, solo grazie all’empatia che può scattare quando non c’è l’omissione.
«Per loro non ero nessuno» o, peggio, «ero da allontanare»: questo il senso delle storie che abbiamo raccolto. Lo abbiamo fatto perché in agosto un aereo si è schiantato all’aeroporto di Madrid e tra i tanti morti c’era un italiano con il compagno e il figlio di lui. Erano seduti a fianco. Sono passati per amici. È scoppiata una polemica sulla mancanza di informazione. Abbiamo assistito a un’omissione del valore delle relazioni, che sono risorse per l’intera società. Le testimonianze qui raccolte mostrano che accade più spesso di quanto si creda. Se le parole salvano la vita, se la vita è anche memoria, chi manipola la memoria uccide una seconda volta. Attenzione: questa non è «solo» una questione esistenziale. È politica. La politica, in America, in Italia, in tutto il mondo, con scelte precise può far emergere la realtà nascosta, ma viva. O al contrario, con scelte blande o solo di facciata, può lasciarla morire. Una, due,
tre… infinite volte.
***
Sono una mamma umiliata
«Mamma Luigi è morto». «Ma che dici, stai scherzando?». Mio figlio era stato a
lungo in attesa di una chiamata, poi un’amica gli aveva dato la notizia. Avevamo cercato subito la madre, ma al telefono non ci aveva detto nulla.
Mi sono trovata accanto a mio figlio al funerale del suo compagno. Nessuno poteva conoscere il mio dolore. I genitori di lui mi avevano avvicinato poco prima dicendo: «I nostri figli erano amici e basta» e con le mani avevano fatto un gesto come a stabilire un confine, a dire: di qui non si passa. Accettai: era la condizione perché partecipassimo al funerale. Luigi per me era un altro figlio. Ascoltavo il prete e pensavo al mio dolore, pensavo al dolore del mio ragazzo. E non sapevo se soffrivo poco o troppo. Il loro legame interrotto da un malore era durato quattro anni. La madre di Luigi non aveva mai voluto incontrarmi. Ci sentivamo per le feste, per scambiarci gli auguri, ma solo per telefono. Luigi veniva spesso a casa nostra. Al funerale eravamo sulla panca in silenzio, incerti se far capire quanto soffrivamo, immaginando che gli altri si chiedessero: chi sono questi? E perché sono così sconvolti?. In genere dei morti non si ricordano le cose brutte così, per uno scherzo troppo amaro, non si doveva sapere dell’amore che aveva reso felice il giovane di cui tutti in quel momento piangevano la scomparsa.
Io mi sentivo umiliata, io e mio figlio eravamo nessuno. Guardavo la madre di Luigi e dicevo: «Ma è questo il momento di pensare a cosa dirà la gente?». E poi aggiungevo: «A lei il figlio mancherà per tutta la vita». Anche a me manca Luigi, ogni tanto gli parlo e lo sento in mezzo a noi, come un tempo. Quando dopo un po’ siamo andati in visita a trovare la mamma di lui, lei capì subito che sarebbe stata la prima e l’ultima volta. Quando Luigi era vivo aveva mortificato tanti slanci per la paura del giudizio sociale. Morto Luigi, era ormai troppo tardi.
(Claudia B. che non si firma per mantenere quella tragica promessa)
***
L’innamorato di mio figlio
Ero da sola a casa la notte in cui seppi della morte di Federico. Allo squillo avevo intuito. La voce lontana e triste di mio figlio, in trasferta con il suo gruppo musicale negli Usa, mi toccò come una revolverata. «E’ morto si è suicidato». Andrea aveva avuto bisogno di comunicarmelo subito.
Qualche tempo dopo avrei trovato nella tasca di una sua camicia da pulire la descrizione accurata del ritrovamento resocontata da un amico, come se Andrea avesse bisogno di fissarla nel tempo e nel luogo. Federico aveva scelto la modalità più scenografica per consegnarsi all’indifferenza del mondo: impiccato alla scala interna della villetta famigliare ove abitavano anche i nonni, nell’ora del pranzo. Fu trovato dal fratellino di ritorno da scuola. Un fratellino che lo aveva fatto sentire più solo che mai nato tanti anni dopo di lui. Coi genitori già da tempo il dialogo si era assopito per quelle misteriose interruzioni di corrente che annunciano l’arrivo dì una sindrome depressiva. Federico a soli 19 anni era convinto che «la vita è in mano ai furbi» isolandosi nella sua camera.
Era spesso a casa mia Federico, lui e mio figlio si conoscevano dall’asilo. Sempre insieme. Mi era capitato di pensare che a Federico potesse piacere Andrea: l’omosessualità nel loro gruppo di amici all’epoca delle medie inferiori era già assodata: Marco uno di loro non faceva mistero delle sue predilezioni. Un giorno Andrea me lo aveva comunicato con la crudezza e la ritrosia dei suoi 12 anni: «Marco è strano». Federico crescendo si faceva silenzioso, Marco si curava da vero gay dichiarato agli amici.
Un giorno che Andrea non c’era Federico venne a casa. Capii dalle parole, dallo sguardo, da tutto. Andrea era il suo grande amore non corrisposto. Pensai alla madre di Federico, una donnetta timida e sottomessa al marito tutta presa dall’adorazione dell’ultimo nato. Fu terribile quando lessi negli annunci funebri per strada che Federico era spirato «dopo lunga malattia». Ma quale «malattia»? Quando chiesi ad Andrea mi guardò sfuggente e disse: «Si è suicidato per una delusione d’amore».
Anna Macchi
***
Il mio corpo invisibile
Avevo ventidue anni. La mia compagna e io eravamo in un bar con alcune amiche in una città del Nord. All’improvviso lei fu scossa da una crisi pazzesca e incomprensibile. Un malore sconosciuto. L’ambulanza arrivò in un lampo. Fu intubata in barella. Salii sull’ambulanza con lei. In ospedale la barella sparì alla mia vista.
Dopo dieci minuti il portantino uscì dicendomi: «Sei qui per quella ragazza? É andata». Non era finita lì. Lei morì ancora. Di notte mi chiamarono i suoi parenti chiedendoci se ci drogavamo. All’obitorio, vidi il suo corpo steso sul lettino e, accanto al suo, il mio. Per gli altri ero invisibile. Uscii prendendo a calci il muro di mattoni rossi. Calci alle morti: alla prima, alla seconda, alle altre che presto sarebbero venute.
Ai funerali il prete disse che era credente (falso). Accanto ai parenti era seduto l’ex fidanzato, lasciato da tre anni. Fu lui a ricevere le condoglianze. Dopo, in privato, lontano dai tanti sguardi in corteo dietro la bara di legno chiaro, alcuni familiari cercarono di sapere cosa ci avesse unite tanto. Tacqui. Quando andai a trovare la madre, lasciai sul tavolo della cucina tutte le foto che ci eravamo scattate: al mare, in corteo, in facoltà. Un mucchio alto quanto un vocabolario. Quel giorno cominciai a uccidere me stessa. Un’infinità di tempo dopo rinacqui e, con me, l’indelebile ricordo della sua inestimabile vita, delle sue numerose morti.
(Delia Vaccarello)
***
Andate via, non siete niente
Enrico ed Osvaldo vivevano insieme in una piccola casa nella campagna bergamasca da una decina d’anni. Un maledetto pomeriggio di 15 anni fa un incidente di moto portò via Enrico. La casa, comprata insieme ad Osvaldo, tutti i fine settimana si apriva per cene e feste. I parenti di Enrico non avevano mai accettato che il loro congiunto, architetto di successo, fosse gay e vivesse insieme a un maestro, di cui tra l’altro i genitori andavano fieri.
La notizia della sua morte ci colpì come una spada infuocata. Mi precipitai in campagna. Nella casa un silenzio lancinante, rotto dai commenti sommessi di decine di amici ed amiche. Osvaldo era in cucina, con lo sguardo fisso. Appena mi vide disse: «Ho appena ricevuto la telefonata di Maria, non dovrò farmi vedere né in camera mortuaria, né al funerale. Sono persona non gradita». Il pianto non si fermò per istanti immensi.
La famiglia d’origine intendeva uccidere la vita di Ernesto. Osvaldo non protestò, si abbandonò con noi per due giorni a vegliare un corpo lontano, un amore interrotto e negato. Ma un’ora prima del funerale, durante il quale dal pulpito un’amica d’infanzia di Ernesto ne avrebbe ricordato la vita, anche se non lo incontrava da decenni, ci vestimmo tutti da cerimonia. Allestimmo in cortile una tavola con tovaglie bianche e fiori d’ogni colore, come piacevano ad Ernesto, e da un registratore posto nel mezzo di un cerchio che avevamo formato, mano nella mano, abbiamo ascoltato «Ma il cielo è sempre più blu» di Rino Gaetano, pezzo che Ernesto adorava.
Il giorno dopo, la «vera famiglia» di Ernesto andò al cimitero. C’erano le corone appoggiate vicino alla tomba, e lì la madre. Arrivarono anche il padre e i fratelli, e uno di loro urlò: «Tu non sei niente, voi non siete niente, andate via, Ernesto non vorrebbe mai che voi foste qui». In fondo aveva ragione, quello era stato l’addio ad un uomo etero: il nostro Ernesto non sarebbe mai stato lì. Oggi Osvaldo e io ci sentiamo di rado e a volte con fatica, ma una cosa ci accomuna: il cielo è sempre più blu ci provoca una tempesta emotiva incontrollabile.
(Aurelio Mancuso)